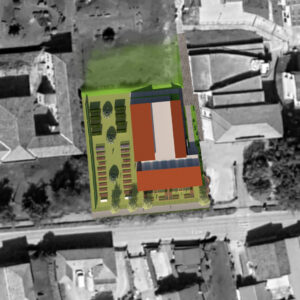Artisti a tavola: ingredienti semplici per una ricetta complessa

L’arte “alimentare” ha una storia antichissima che incontra il gusto dell’ostentazione della ricchezza, i complicati messaggi religiosi del cibo legati all’eucaristia e la “fame” come “grado zero” della condizione umana
Arte e cibo: un binomio perfetto, un’accoppiata vincente si direbbe, soprattutto in un Paese come il nostro che della tradizione culinaria ha saputo fare un’arte e che, quasi come in un gioco di specchi, nelle arti figurative ha trovato una delle vie per esprimere tale “vocazione”, se così possiamo definirla. Per averne diretta conferma possiamo andare indietro nel tempo, alle radici dell’arte occidentale, e “assaporare” – per non uscire dalla metafora – le prove illusionistiche dell’arte classica, che con il celebre tema dell’asàratos òikos (o, più semplicemente asaraton), il “pavimento non spazzato” – suggestivo antenato della natura morta – fissa nei repertori iconografici la rappresentazione di quello che doveva essere la fine di un sontuoso banchetto.
Molto spesso la rappresentazione del cibo nella tradizione figurativa non è disgiunta da significati ‘altri’, carichi di valore simbolico
Il soggetto, ideato nel II secolo a.C da Sosos di Pergamo e diffuso nei repertori musivi, vede infatti la singolare messa in scena di un pavimento ricoperto da resti di cibo, in cui si possono osservare frutti, lische, ossa di pollo, gusci, molluschi, conchiglie, come è ad esempio nel bel mosaico dei Musei Vaticani, proveniente da una villa di età adrianea dell’Aventino, o ancora, per avvicinarsi al nostro territorio, nel meraviglioso trompe l’oeil di Aquileia. Destinato a decorare le sale del triclinio, la sala da pranzo della domus romana, l’asaraton certifica la magnificenza e la ricchezza del suo committente: non è solo un mero gioco d’illusione a scopo decorativo – per quanto affascinante – bensì un vero e proprio manifesto di auto-promozione sociale.

Asaraton di Aquileia
Va detto infatti che molto spesso la rappresentazione del cibo nella tradizione figurativa non è disgiunta da significati ‘altri’, carichi di valore simbolico. Così è ad esempio nelle tavole imbandite delle splendide Ultime Cene rinascimentali, dal Cenacolo per antomasia, quello di Leonardo in Santa Maria delle Grazie a Milano, ai Cenacoli fiorentini, in cui spiccano la versione quattrocentesca di Andrea del Castagno in Santa Apollonia e quella elegantissima, “sanza errori” avrebbe detto Giorgio Vasari, di Andrea del Sarto a San Salvi. E ancora quelle, passando in Veneto, di Jacopo Tintoretto e Paolo Veronese, decisamente più ricche e variegate. Naturalmente in questi casi la presenza del cibo si collega al significato religioso di pertinenza: il pane – quello che appare in abbondanza ad esempio nel telero di Tintoretto in San Giorgio a Venezia – è già preludio dell’ostia, ed è dunque pane della salvezza, dal valore sacramentale. Nel dipinto veneziano, dove bene è rappresentata questa doppia valenza – materiale e spirituale insieme – vediamo infatti un bellissimo Cristo sacerdotale che offre l’ostia agli apostoli, disposti lungo il tavolo in scorcio ed immersi in un’atmosfera allucinata, percorsa dai bagliori sprigionati dalla lucerna arroventata e da un turbine di angeli evanescenti. È questo un brano di vibrante intensità espressiva, idealmente sospeso tra la rappresentazione della prosaica realtà quotidiana, con la bellissima tavola imbandita ricoperta di “coppe […] boccie di Murano, […] piatti colmi di ova, di frutta, di erbaggi” (Luigi Coletti), e la trasfigurazione visionaria della stessa, resa nei termini stilistici di un maturo luminismo integrale.

Nell’Ultima Cena del Tintoretto, il pane ha una doppia valenza: materiale e spirituale
La rappresentazione del cibo, in questo caso (e in infiniti altri dello stesso periodo) rientra all’interno di una precisa iconografia codificata, dove la grandezza dell’artista non consiste – come sarà dopo le avanguardie del Novecento – nell’originalità dell’invenzione ma nella capacità di variare i dettagli, precisi portatori di significato, al fine di creare situazioni nuove – in primis mediante associazioni visive, ricreazione delle metafore, usi specifici dei simboli – all’interno di un sistema di immagini già “regolamentato”. Notevole, sempre nella tela di Tintoretto, la straordinaria capacità di creare il nesso retorico con la Caduta della Manna, collocata di fronte: il nuovo pane sacramentale infatti non solo ha sostituito il pane azzimo del rito ebraico, ma ha simbolicamente sostituito la manna, come sembra suggerire la donna in primo piano che offre all’uomo di spalle una coppa di confetti del tutto simili alla manna dell’altro dipinto, ostentatamente rifiutati in favore della frutta perché il pane del deserto è ormai sostituito dal nuovo pane dell’Eucarestia. Lo stesso concetto si può applicare a infiniti altri esempi, anche alle famose “frutte” di Caravaggio, realizzate verso la fine del Cinquecento: strepitosi brani di naturalismo che non vogliono tuttavia essere semplici riproduzioni della realtà quanto allusioni a precisi valori simbolici: così è per la Canestra di frutta della Pinacoteca Ambrosiana, la celeberrima “Fiscella”, che rappresenta al massimo grado – per qualità e precisione analitica – il genere della “natura morta”, di origine come s’è visto ellenistica, ma tornato in auge alla fine del Cinquecento e diffuso in Europa lungo tutto il Seicento. Se infatti osserviamo la frutta raffigurata scopriamo che non è perfetta come sembra, bensì segnata da piccole imperfezioni, a suggerire la fragilità della vita, secondo il tema della vanitas allora in voga. Innumerevoli sono gli esempi analoghi: dai fiamminghi come Pieter Claesz, i Van Haelst o de Hee, solo per citarne alcuni fra i più noti, ai bodegones di Velazque, dalla scuola napoletana di Giuseppe Recco e Paolo Porpora, a quella milanese di Fede Galizia o a quella toscana di Bartolomeo Bimbi, autore di quadri “ripieni di tutte le sorte di frutte, d’agrumi, d’uve, di fiori… sì di naturali come di stravaganti aborti della natura” (Filippo Baldinucci).

Eppure non è solo questo, c’è un’evoluzione: la natura morta è anche un “oggetto teorico”: immagine in cui il tema è l’immagine – non una “storia”, per quanto allegorico-mitologica, né una semplice rappresentazione. E a volte è invece “commento” alla scena: come nella “finta” natura morta di Peter Aersten, a Vienna, nel Cristo in casa di Marta e Maria, dove la scena evangelica è relegata in fondo a sinistra, e protagonista è il trompe l’oeil con diversi oggetti ammassati, apparentemente senza senso. Il senso invece c’è, ed è il nesso tra gli oggetti in primo piano e il significato evangelico della scena nello sfondo: a richiamare Cristo è infatti il grande coscio d’agnello, e in modo ancora più sottile il garofano conficcato in quello che sembra un pezzo di burro e che invece è da identificarsi con il lievito: garofano in latino è detto carnatio, ed è dunque un perfetto simbolo dell’Incarnazione, legato al lievito, che non è ancora pane ma materia che attende la trasformazione ed è destinato a crescere. Secoli più tardi questi temi troveranno una nuova conversione: spogliati del manto allusivo saranno al centro di vere e proprie denunce sociali, come è nei Mangiatori di patate di Van Gogh (1885), opera anti-retorica per eccellenza, permeata di crudo realismo, idealmente memore di quel Mangiafagioli secentesco di Annibale Carracci, dove però era il realismo in sé ad attirare l’artista, senza traccia di denuncia sociale. Più giocosi del maestro olandese, ma non meno taglienti, erano stati poco più di un secolo prima i grandi maestri del Settecento veneziano, Giambattista Tiepolo ed il figlio Giandomenico che nei Pulcinella che mangiano gli gnocchi raffigurano un’umanità rappresentata nel suo “grado zero”, quello che vive unicamente nelle pulsioni più semplici, senza considerare le grandi complicazioni che nel corso del secolo dei Lumi interessavano sempre più le cerchie intellettuali. Ancora una volta, una figura che appare semplice, ma si riveste di significati complessi a sancire l’inizio della modernità.