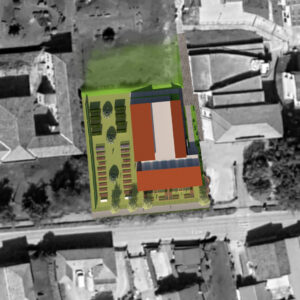Eserciti di “cavalièri” sui castelli, nelle case dei nostri contadini di ieri

Per tutto l’Ottocento e buona parte del Novecento la bachicoltura fu un’attività esercitata a livello domestico. I membri dell’intera famiglia venivano mobilitati nell’allevamento, la vendita dei bozzoli permetteva di superare i momenti difficili
Se entrassimo oggi nella casa di un contadino di neanche un secolo fa, forse ci stupiremmo di trovare in cucina non un televisore, un microonde, una macchinetta per il caffè espresso, ma un castelletto fatto di pali e graticci con dei bruchi sopra, intenti a divorar foglie di gelso. Sì, insomma, oggi che le nostre case “profumano di pulito” e si va di “swifferone” per togliere la polvere, anche senza spostare i soprammobili, avere nel tinello un esercito di “cavalieri” che producono con le loro mascelle un ininterrotto rosicchio di sottofondo potrebbe risultarci alquanto inquietante. Se una blatta o un ragno possono portare al panico, con una processione di larve in cucina
crollerebbe anche la casalinga più imperturbabile. Eppure, solo sette o otto decenni fa era la norma.

I bachi da seta in dialetto veneto venivano chiamati “cavalieri”
L’attività, in realtà, era iniziata molto tempo prima del secolo preso in considerazione all’inizio di questo articolo, la Repubblica di Venezia della bachicoltura aveva fatto un punto di forza della sua economia. Le sete veneziane erano apprezzate in tutto il mondo e la Domiante aveva introdotto norme severissime per proteggerne la produzione e i segreti di realizzazione. Ma i primi anni dell’Ottocento, caratterizzati da guerre, da epidemie – come la filossera che colpì la coltivazione del vino – e carestie che ridussero la coltivazione dei cereali, l’allevamento del baco da seta fu per le fami contadine un’attività che aiutò spesso a sopravvivere, portando una certa disponibilità
liquida di denaro in tempi difficili.
La malattia del 1856 fece crollare il raccolto dei bozzoli nel vicentino da 2 milioni di chilogrammi a 156 mila, causando il calo di almeno un terzo degli allevamenti
L’attività ebbe un incremento frenetico: nel 1830 nel Padovano, ad esempio, venne triplicata la coltura del gelso, favorita dal governo austriaco e dal sostegno della propaganda. “Se vuoi diventar ricco – scrivevano – pianta gelsi” oppure “Chi ben coltiva ‘l moro (gelso) coltiva nel so canpo un gran tesoro”. E piantare gelsi era piuttosto comodo in quanto non sottraeva spazio ad altre colture, i “morari” trovavano spazio lungo i corsi d’acqua o nei terreni marginali, e la manodopera per l’allevamento dei bachi era facilmente reperibile in casa: donne e bambini potevano essere impegnati nella pelatura della foglia. Inoltre il lavoro si concentrava in un periodo abbastanza corto, circa i 40 giorni necessari per la trasformazione del bruco in crisalide. Unico punto dolente: la mancanza di filande industriali nel territorio alle quali vendere direttamente i bozzoli, quest’assenza dava un’eccessiva forza contrattuale ai commercianti che in pratica imponevano il prezzo al contadino. Non meno disastrose per le nostre famiglie erano le morie che colpivano il baco da seta come la malattia del 1856 – la pebrina o atrofia parassitaria – che fece crollare il raccolto dei bozzoli nel vicentino da 2 milioni di chilogrammi a
156 mila, causando il calo di almeno un terzo degli allevamenti, malgrado l’aiuto delle stazioni bacologiche sorte in quegli anni per debellare le nuove malattie.

I bozzoli del baco da seta. Galéte in dialetto veneto
Ma nonostante queste difficoltà, nella povera economia contadina veneta la bachicoltura restò ancora remunerativa.
Intorno al 1860 a Lonigo, ad esempio, si contavano ancora 12 “filatori di seta” che davano lavoro a 220 operai. Dopo, l’industria della seta, iniziò una lenta ma progressiva decadenza, accentuatasi con la crisi del 1929, quando cessarono di colpo le esportazioni in America. A questa poi sono da aggiungere la concorrenza delle fibre artificiali e sintetiche, la fuga dalle campagne della popolazione rurale, il più ampio uso di pesticidi in campagna.
Tutti elementi di una modernità del tempo che contribuirono a dare il colpo di grazia alla bachicoltura, la cui produzione toccò i minimi storici negli anni Sessanta del Novecento.
Ma torniamo ai nostri vecchi. Quando ai primi tepori di primavera sui gelsi incominciano a spuntare le foglioline, i contadini mettevano a nascere i bachi da seta”. Entro San Marco, 25 aprile, acquistavano le uova, ma qualcuno riusciva anche ad autoprodursele. I locali che le avrebbero accolte, insieme ai graticci, ai sostegni, ai castelli e tutta l’attrezzatura usata, comprese le ceste e i sacchi per la raccolta della foglia, erano oggetto di
scrupolose pulizie. Le camere dovevano essere asciutte, sane e arieggiate, un mese prima venivano imbiancate con latte di calce, disinfettate, e i pavimenti lavati con liscivia di cenere bollente o soda.
Intorno al 1860 a Lonigo si contavano ancora 12 “filatori di seta” che davano lavoro a 220 operai e a numerose famiglie impegnate nell’allevamento dei bachi
Tutto questo deponeva a favore della salute di questi insetti. Si faceva in modo che i “bacolini” nascessero negli ultimi giorni di
aprile o ai primi di maggio, regolandosi con la stagione in modo che nascessero quando i gelsi incominciavano a “buttare” la foglia. L’incubazione doveva avvenire in una camera tiepida (18°-24°), oppure in cucina, con aria e luce, ma fuori dalle correnti d’aria. Altrimenti si doveva prendere un setaccio grande da farina, e sopra una carta ben distesa vi si mettevano dentro le uova, si copriva poi il setaccio con un panno e lo si poneva sopra una sedia capovolta, senza il fondo, ben assicurata, sotto la quale si metteva un braciere con braci coperte di cenere, lontano almeno un metro dal setaccio.
La salute dei bachi era affidata al divino: il giorno di Pentecoste si svolgevano processioni propiziatorie, il patrono era S. Giorgio, ma si ricorreva anche a S. Antonio da Padova e alla conclusione della stagione si ringraziava “la miracolosa immagine di Maria Vergine”
Dopo la schiusa iniziava l’allevamento in cui tutta la famiglia era coinvolta, gli uomini sulla scala a pelare i morari, i ragazzi a portare le foglie a casa senza pressarle (non dovevano fare el bojón, fermentare), le donne a dar da mangiare di continuo a queste bestiole insaziabili che non conoscevano orari. La salute dei bachi, invece, era affidata al divino: il giorno di Pentecoste si svolgevano processioni propiziatorie, il patrono era S. Giorgio, ma si ricorreva anche a S. Antonio da Padova e alla conclusione della stagione si ringraziava “la miracolosa immagine di Maria Vergine”. Verso la metà di giugno, qualche giorno dopo la quarta muta, i bachi smettevano di mangiare. Lucidi e trasparenti, di un bel colore giallognolo o bianchiccio a secondo della qualità, camminavano sulla foglia rizzando la testa: erano maùri (maturi), pronti per salire sul bosco di fascine dove il bruco iniziava a tessere il suo bozzolo (galéta). Al buio, con le finestre oscurate, i cavalièri incominciavano quindi a filare. Dopo circa una settimana, e cioè quando diventavano duri e si era staccato il baco all’interno, i bozzoli dorati o bianchi erano pronti per essere raccolti per essere venduti. Il prezzo veniva trattato dai sensali o mediatori, gli stessi che avevano contrattato l’acquisto del seme o dei bacolini.

Seta
Dopo la pesatura, i bozzoli venivano riposti dai negozianti nelle zhéste da galéte (lunghe ceste di vimini, a sezione rettangolare), e avviati coi carretti trainati dai cavalli verso le filande del territorio. Prima però sarebbero stati portati negli essiccatoi dove, per mezzo del calore, si facevano morire le crisalidi, che altrimenti, tramutate in breve in far falle, avrebbero bucato il loro nido per uscire a deporre
le uova, togliendo così al bozzolo ogni valore. Verso San Giovanni (24 giugno) il tempo dei cavalieri era finito, e il contadino poteva vedere
il primo guadagno dell’annata. Ma la stagione avanzava, e altri lavori, forse più incalzanti, lo attendevano.
Questo articolo cita parti tratte da “Attività agricole e tradizioni venete nelle collezioni di Carlo Etenli” di Flavio Dalla Libera