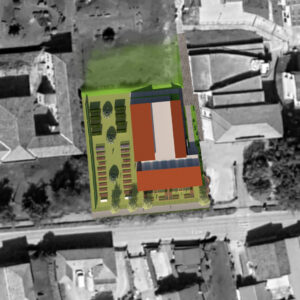Scudellari, antichi e anonimi artigiani del Veneto rinascimentale

I loro nomi non compaiono a fianco dei grandi pittori, ma pure sono stati dei maestri che tra la fine del Medioevo e il XVII secolo hanno contribuito ad divulgare il linguaggio simbolico dell’arte
Siamo abituati ad immaginare il Veneto come uno dei centri europei della produzione artigianale. I nostri nonni erano soliti “usarsi” l’appellativo di “maestro” nel salutarsi e nei convenevoli, sentendosi orgogliosamente figli legittimi dell’ingegno e di quell’intraprendenza italiana che ha conferme nel Rinascimento, seppur il nostro discorso segua il ramo delle arti applicate.
I cognomi veneti molto spesso sono nomi di mestieri e “Pegnataro” o “Pegnata” o “Bocalaro” indicavano l’antica arte di chi produceva piatti, ciotole, brocche e pignatte
Per chi ha la mia età ricorderà i ruggenti anni ’80 e ’90 della “locomotiva del Nord Est”, lanciata veloce sui binari del mobile e del tessile e purtroppo anche la successiva dissoluzione, ben prima che la crisi economica, iniziata con il fallimento della Lehman Brother’s, e i denti aguzzi della globalizzazione rendessero “provinciale”, e dunque “marginale”, la produzione. E’ stato sicuramente uno schiaffo che in una terra di falegnami come la nostra, dove l’arte del legno era stata tramandata da padre in figlio dai tempi eroici dei “marangoni” che fecero dell’arsenale di Venezia la prima industria al mondo, si sia insediato il colosso svedese dei mobili di cartone. Va beh, ironia della sorte o segno dei tempi, cambia poco: “magna e desmentega” è uno dei motti con i quali ci siamo lasciati alle spalle anche le tragedie più crude. E del resto sono molti i mestieri di cui abbiamo perso memoria. Restano i nomi, anzi i cognomi perché il lavoro in una terra come la nostra ha sempre significato identità e quindi ancora oggi ci portiamo addosso: Marangon, Lanaro, Scarparo, Favaro, Sartor, etc, etc. Gente viva chiamata con mestieri morti. Nulla da rimpiangere, per carità! Ma c’è una storia che merita di essere raccontata, quella degli “scudelari”, cognome ancora molto diffuso, anche se il mestiere a cui si riferisce non lo conosce più nessuno. Altri nomi per indicare lo stesso lavoro era “pegnatari” o “pegnata”.

“Bocalaro” invece non ha avuto il privilegio di diventare cognome, forse perché attribuito a qualcuno poteva far correre il rischio a questi di essere identificato come uno facile agli sproloqui o artista della parola a vanvera. Quando, invece, artista lo era davvero, nel senso che gli “scudelari” e i “pegnatari” erano “maestri” del tornio e armati di colori e pennelli hanno lasciato una traccia indelebile con una produzione di ceramiche che oggi viene definita dagli storici: “graffita ad ingobbio”. Una produzione specificatamente veneta, a quel tempo fenomeno dell’Est più che del Nord Est, perché stiamo parlando di quella Repubblica di Venezia che alla fine del Medioevo si sentiva a casa in ogni angolo dell’Oriente e del Mediterraneo.
Artisti del tornio, armati di colori e pennelli hanno lasciato una traccia indelebile con una produzione di ceramiche che oggi viene definita dagli storici: “graffita ad ingobbio veneta”
Furono proprio i mercanti veneziani ad impararne o ad importarne, insieme alle prime maestranze, la tecnica da Bisanzio, per poi diffonderne la produzione nelle terre in cui esercitava la sua influenza e il commercio in tutto il Nord Italia. In poco tempo sorsero dei centri di produzione in Emilia, dove si distinse Ferrara, Bologna e Faenza, in Lombardia, con Mantova, e ovviamente in Veneto dove le botteghe sorsero in città come Padova, Verona, Rovigo e Treviso ma molte fornaci trovarono fortuna anche nei paesotti lungo l’asta dell’Adige, come quelle di Anguillara, di Badia Polesine, di Masi o di Legnago, rimaste attive per diversi secoli. Infatti fu una produzione di successo, capace di continuare ad incontrare il gusto, e quindi un florido mercato, fino alla fine del ‘600 con minime variazioni di produzione e di stile.

Una fortuna più che altro trovata nella facile realizzazione di questi prodotti e forse, ancor di più, nella loro economicità, tanto che la tecnica dell’ingobbio rimase efficace anche nel corso del XVI secolo quando i nostri “scudelari” a fianco della produzione tradizionale presero ad imitare le lucide e costosissime porcellane cinesi, bianche e blu, prodotte con il caolino. Insomma, al tempo, i “cinesi” eravamo noi, capaci di “copiare” i prodotti della gran moda, ma a poco prezzo. E anche nel caso della “graffita” si potrebbe parlare di plagio, perché tutto il ricco repertorio di immagini utilizzate per la decorazione provenivano dall’iconografia bizantina, che a sua volta risentiva di quella persiana.
Al tempo, i “cinesi” eravamo noi, capaci di “copiare” i prodotti della gran moda, ma a poco prezzo. E anche nel caso della “graffita” si potrebbe parlare di plagio
Il campionario di astratte raffigurazioni geometriche, rispondenti all’iconoclastia dell’Asia Occidentale, insieme al bestiario di figure fitomorfe e zoomorfe dalla grafica semplificata, ma fortemente simbolica, bizantina, rimase attuale anche al di fuori dei messali, dei salteri e dai libri d’ore dai quali erano stati desunti e soprattutto anche in un tempo in cui il Rinascimento aveva aggiornato il linguaggio dell’arte. Nella arti applicate, come la ceramica, il linguaggio rimase resiliente, si modernizzò con maggiore lentezza, anche se una certa evoluzione c’è stata. Ma forse fu proprio la destinazione popolare della produzione a rendere meno pressante il bisogno di aggiornare l’iconografia o proprio l’universalità di quelle immagini, fortemente evocative e comprensibili a tutti, come gli emoticons dei giorni nostri, a decretarne una lunga sopravvivenaza.

E quindi nei cavetti di ciotole e piatti, incorniciati da linee continue intervallate da racemi, losanghe e festoni polilobati gli “scudellari” continuarono a dipingervi le immagini di un campionario studiato più che altro in ragione alla committenza: simboli augurali di fertilità come cervi e conigli nel caso di una produzione rivolta a giovani sposi (la ceramica graffita sta anche alle origini delle bomboniere) simboli come la croce di San Bernardino o il melograno, destinati agli ordini religiosi, pesci ed uccelli come auspicio di abbondanza. E tra i soggetti di successo non mancava il “nodo”, considerato un talismano orientale, la stella di David, un segno propiziatorio, il cerchio, la losanga tagliata in croce, gli alberi (vegetante e secco), la rosa e il giglio, le rosette di buon augurio graffite sullo sfondo accanto a teste per lo più di profilo o a figure a mezzo busto rappresentate entro un giardino fiorito (hortus conclusus) luogo d’amore e di letizia per eccellenza. E poi scudi araldici e le iniziali dei nomi con lettere in onciali gotici entro verzieri di foglie e girali d’acanto per una committenza più d’alto rango.

La qualità della decorazione variò molto anche nello stesso centro di produzione e nello stesso periodo: accanto a stoviglie dal disegno semplicissimo, ma pur sempre gustoso, destinate all’uso corrente, sono state trovate ceramiche con raffigurazioni estremamente elaborate ed elegantissime, segno di una produzione già attenta alle leggi del mercato, che sapeva adattarsi alle possibilità di spesa e al gusto della committenza.
Non è raro imbattersi accidentalmente in un frammento di questa particolare produzione a chilometri zero
La storia non ci ha restituito nomi di scudellari illustri, non c’è un Tiziano, un Tintoretto o un Giorgione tra di essi, tuttavia la loro produzione è ancora ben documentata, non esiste museo che non ne conservi un piatto, una ciotola, un boccale. Ma anche la nostra campagna ne conserva traccia, a tutti gli effetti sotto forma di inquinamento, antesignano anche questo a tanta produzione veneta, perché tutto ciò che non superava le due cotture (era circa il 40%) veniva distrutto gettandolo nei fiumi, oppure usandolo come materiale inerte per coprire buche o compattare argini e terrapieni. E così non è raro imbattersi accidentalmente in un frammento di questa particolare produzione a chilometri zero, come è capitato a me, e magari di pensare a quante cose “si mangia” il tempo e la terra o i fiumi, invece, no.