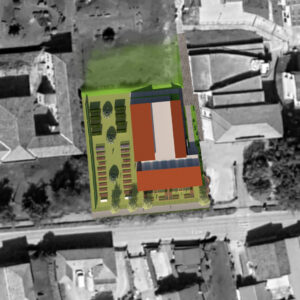Veneto contemporaneo nello specchio dei suoi scrittori (parte prima)

Il centenario dalla nascita di Luigi Meneghello offre lo spunto per una riflessione sul racconto che gli autori veneti hanno fatto della nostra regione negli ultimi sessant’anni. Vale la pena chiedersi se l’immagine letteraria del Veneto corrisponda a quella percepita da ognuno di noi
Già negli anni ’60 del Novecento era chiaro agli osservatori più sensibili che il Veneto stava subendo una trasformazione epocale: una rivoluzione industriale e antropologica che travolgeva rapidamente la cultura contadina, un certo artigianato, un certo modo di fare commercio, il paesaggio.
I letterati veneti ne colgono tempestivamente la portata: è del 1963 l’apparizione di “Libera nos a Malo” di Luigi Meneghello (1922-2007), dove l’autore traccia il ritratto (affettuoso, divertito, ironico, critico, pensoso) del suo paese d’origine, com’era attorno al 1920-30.

Meneghello: “Il paese era una struttura veramente fatta a misura dell’uomo, fatta letteralmente dai nostri compaesani, e quindi adatta alla scala naturale della nostra vita”
“Probabilmente non è il caso, parlando di questi modi di vita, di tirar fuori la parola cultura. In un solo senso c’era una nostra cultura paesana, e cioè come costume tradizionale, un sistema di rapporti e di valori ben definito e articolato…Aveva però la potenza delle cose vere, mentre il codice culturale ufficiale, espresso per iscritto in una lingua forestiera [l’italiano], dava l’impressione di una convenzione vuota…” Era una società dominata dalla fatica, dal tribolare del contadino, svolta sotto il segno della necessità.

Libera nos a Malo è l’opera più significativa dello scrittore vicentino Luigi Meneghello. Pubblicato nel 1963 è una sorta di rivisitazione autobiografica degli gli usi, dei costumi, delle figure tipiche, della vita sociale che l’autore ha conosciuto nel corso della sua infanzia e giovinezza nel paese na-tale e traccia un ritratto della provincia vicentina, della sua gente e della sua cultura dagli anni ‘30 ai ‘60 del Novecento
Tuttavia il paese non era il contado, poiché esso “travasava e raffinava il costume campagnolo”, fino a staccarsene anche nell’uso di un dialetto leggermente diverso. Il paese ospitava infatti una borghesia di commercianti e soprattutto artigiani per i quali “la virtù somma è l’abilità tecnica, la ‘virtus’ dell’artefice”, il gusto del lavoro ben fatto. “Il paese era una struttura veramente fatta a misura dell’uomo, fatta letteralmente dai nostri compaesani, e quindi adatta alla scala naturale della nostra vita. Quello che c’era era stato fatto in buona parte lì, oggi invece le cose [fabbriche, strade, mode] scendono dall’alto”. Fondamentale, per Meneghello, è che si trattasse di una cultura del tutto orale, che si esprimeva in dialetto: “la parola del dialetto è sempre incavicchiata nella realtà, per la ragione che è la cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare e non più sfumata in seguito dato che ci hanno insegnato a ragionare in un’ altra lingua…Ma questo nòcciolo di materia primordiale…contiene forze incontrollabili proprio perchè esiste in una sfera pre-logica dove le associazioni sono libere e fondalmentamente folli. Il dialetto è dunque per certi versi realtà e per altri follia”. E motivo non ultimo del godimento che quel testo ancora procura sta proprio negli spericolati giochi linguistici cui l’autore si abbandona, sollecitato dall’ evocazione di una parola, dal ricordo di una filastrocca.
Molto diverso è il tono de “Il Quinto Stato” di Ferdinando Camon, edito nel 1970 e seguito nel ’72 da “La vita eterna” e nel ’78 da “Un altare per la madre”, a comporre la “trilogia degli ultimi”. Il primo libro è uno spietato resoconto, una testimonianza “dall’ interno” per essere stata vissuta direttamente dall’autore, di un mondo contadino (quello della bassa padovana) senza storia perchè da millenni, forse, sottoposto agli stessi dolori, fatica, fame, soprusi, malattie, un mondo “altro” e indicibile. Ricordare è, allora, “intraprendere il cammino del riscatto e della liberazione” (Cesare De Michelis). Nei testi successivi si fa largo la consapevolezza della drammatica rottura che travolge e dissolve quella cultura “con l’arrivo della luce elettrica, databile agli anni sessanta, e della televisione, quasi contemporanea”, e alla coscienza della fine si accompagnano l’amorosa pietà, la ferma attenzione e il profondo rispetto con cui lo scrittore ne ripercorre valori e comportamenti (De Michelis).



“Il Quinto Stato” edito nel 1970 e seguito nel ’72 da “La vita eterna” e nel ’78 da “Un altare per la madre” costituiscono la “trilogia degli ultimi” che Ferdinando Camon dedica alla propria terra
Certo, il mondo contadino del Veneto non è (era) una realtà compatta e univoca variandone molto le carattestiche in base alla conformazione dei diversi territori, alla diversità della loro storia economica e sociale. C’è il Polesine di Gian Antono Cibotto, c’è la bassa veronese esplorata in molti libri da Dino Coltro, la bassa padovana narrata da Roberto Valandro e Camillo Corrain, c’è la vicentina Vel Leogra studiata da Terenzio Sartore…
Mario Rigoni Stern, pur riconoscendo il degrado del paesaggio non cessa di credere nel valore pedagogico della tradizione e nella possibilità di un rapporto armonioso con la natura

La beltà è una raccolta in versi di Andrea Zanzotto, pubblicata la prima volta a Milano nel 1968 da Mondadori
Così, nell’ altipiano di Asiago, che non ha mai conosciuto la figura del paron, del nobile possidente, e amministrato per secoli da una comunità autonoma, Mario Rigoni Stern, pur riconoscendo il degrado del paesaggio causato dall’abbandono e dal turismo di massa, non cessa di credere nel valore pedagogico della tradizione e nella possibilità di un rapporto armonioso con la natura. Fondandolo sulla cura, sulla somma di conoscenze – che appaiono quasi istinto – del montanaro del passato, che sa di meteorologia zoologia botanica… non per via di scienza ma per un millenario sapere, sviluppatosi in un simbiotico dare ed avere tra uomo e natura (e che scienza e tecnica potranno semmai implementare).
Accenni, questi, che si colgono anche nella raccolta di poesie di Andrea Zanzotto “La Beltà” (1968). “Fine delle sofferenze contadine/ delle mosche e della grassa” [letame] annuncia ironicamente, per constatare subito dopo che questa fine ha come contropartita l’abbandono dei campi, ora terrain vague disponibile all’edificazione e conquistato da topi, serpi e talpe (LB, XVI). Solo Nino [Mura] resiste, lui “tradizionista a sera all’alba novatore”, che “motorizza elettronizza e televisivizza”. [Ma tu, Nino] “frughi gli arcani del tempo e della natura,/ e -più conta- dai cieli stessi derivi il tuo vino/ chè le tue vigne con lo stellato soltanto/ confinano e col folto degli stellanti fagiani./ Tu qui le tempeste e le nevi prevedi del domani…” (LB, III).