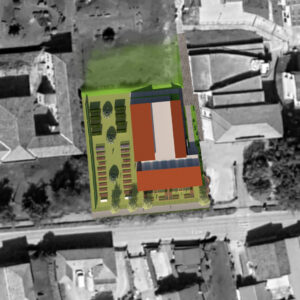Il generale Inverno, ricordi e cronache d’altri tempi

Il Novecento conserva memoria di tre inverni veramente terribili: il ’29; il ’56 e l’85. Rigori che tuttavia erano la norma tra il XIV e il XIX secolo, quando per cinquecento anni infuriò la “Piccola era glaciale”
“Fin da Nàdale fredo non fa: braghe da istà,
dopo Nàdale fredo passà: braghe da istà”
Eppure il freddo c’era. La sua sagoma ingombrante e invadente era una triste compagnia, soprattutto per chi aveva pochi mezzi per tenerlo a bada. Ospite decisamente sgradito, non aveva problemi a entrare nelle case della povera gente, a sedersi a tavola con loro durante il pranzo, la cena, a stendersi nelle cuccette, insieme ai corpi raggomitolati nel buio sotto misere coperte, e a risvegliarsi al mattino ancora una volta inclemente. Gelava l’acqua nei bicchieri sul comò, il freddo, e rigava con una secca bava di ghiaccio le sottili lastre di vetro alle finestre, anche dalla parte interna delle camere di quei contadini che fino a sette-otto decenni fa abitavano le nostre campagne. Erano loro a soffrire massimamente la morsa del freddo. L’endemica povertà rendeva le stagioni rigide vere e proprie epidemie che mietevano vite umane. Non c’era scampo dal gelo, non c’era nulla o quasi che potesse allentare la sua morsa ai piedi, alle spalle, alle membra di vecchi, donne o bambini: niente negli armadi, salvo uno scialle o qualche paio di calze di lana rammendato mille volte, niente nelle bocche dei camini dove la legna era rara e più spesso ci finivano le “brecane” e le sterpaglie, gettate sulla misera fiamma ancora ricoperte di brina. Buone appena ad affumicare le stanze o a scaldare i palmi delle mani e le guance dei visi, mentre le schiene e le articolazioni rimanevano preda della penombra delle stanze e dell’umidità.
La stessa umidità che si condensava insieme agli sbuffi della polenta fumante tra le brecce delle tavole dei soffitti, perché il calore nelle case dei contadini aveva anche un odore, quello appunto dei cibi, ma anche quello meno inebriante della stalla, dove le anime si stringevano attorno ai grossi corpi delle “bestie” in quella forma di socialità che tra i veneti è conosciuta con il nome di “filò”. E’ quindi immaginabile che tra le speranze ci fosse quella di un inverno breve, l’auspicio che magari il Generale Inverno togliesse l’assedio subito dopo Natale.
Il calore nelle case dei contadini aveva anche un odore, quello dei cibi, ma anche quello meno inebriante della stalla
Eppure i ricordi, anche più desolanti, dei rigori che popolano la memoria rurale delle nostre campagne degli ultimi secoli, possono essere assimilati alla “frigidità” di una granita alla menta se confrontati con quelli di epoche precedenti. Gli inverni del ‘29, del ‘56 e del ‘85, archiviati come terribili nella storia del Novecento, proprio per il “grande freddo”, erano tutto sommato la norma in quei cinquecento anni che, dal XIV a XIX secolo, gli esperti della meteorologia definiscono “Piccola era glaciale”. Freddi capaci di fermare il corso dei fiumi e le maree delle lagune, di coprire paesi e villaggi sotto cumoli di neve per settimane, creando patimenti che non è difficile immaginare ancora più tremendi, per quei contemporanei le cui condizioni di vita non erano del tutto dissimili della miseria raccontata dai nostri nonni. Così vien da chiedersi come abbiano fatto quelle povere plebi ad affrontare l’inverno 1431-32, quando le cronache del tempo registrano con scalpore non tanto il totale congelamento del Po, ma piuttosto che il grande fiume fosse rimasto ghiacciato per oltre due mesi. Nello stesso anno, anche il congelamento in profondità delle acque della laguna di Venezia – così che i carri potevano fare comodamente avanti e indietro tra Mestre e Venezia – sembra rientrare tutto sommato nella norma, segno che il fenomeno al tempo era molto più frequente di oggi, tanto che per l’approvvigionamento idrico della città, nei momenti di isolamento, era in pratica un collaudato sistema di barche precedute da persone attrezzate di pesanti martelli, con i quali veniva spaccato il ghiaccio davanti agli scafi, per la spola tra le rive cittadine e la foce del Brenta.

La “laguna ghiacciata alle Fondamenta Nuove nel 1708”. L’opera, di un autore anonimo, deriva da un’incisione di Vincenzo Corelli. La laguna ghiaccia raramente, circa un paio di volte al secolo, ma ben cinque volte nel Settecento, diventando interamente percorribile da Venezia alla terraferma. La gelata del 1708 venne popolarmente attribuita alla venuta di Federico IV di Danimarca e Norvegia a Venezia, il 29 dicembre di quell’anno
Non di meno le precipitazioni nevose erano più frequenti di oggi e più imponenti negli accumuli: nel 1448-49 la neve caduta al suolo superò l’altezza di una persona, così pure nel 1481-82, mentre nel 1489-90 a Venezia nevicò addirittura per dodici giorni consecutivi. Della nevicata del 1608 rimane testimonianza in un manoscritto, conservato nella Biblioteca Civica di Padova, di Nicolò De Rossi che fedelmente riporta: “In questo anno molto calamitoso per le continue e grandissime neve che per due mesi e mezzo, che veramente mostrò un diluvio grande di neve che fu cosa inaudita il vedere una tanta quantità che per memoria di vecchi non si ricorda mai tanto naufragio che a pena si potevano vedere li huomini da una parte e l’altra delle strade, li coperti delle case non erano sicuri perché bisognava che con forti travi fossero appuntellati, e continuamente ogni altro giorno farla gettare giù nelle strade con gran spesa…”. Gli inverni continuarono a susseguirsi terribili per tutto il XVII secolo, con picchi di freddo nei decenni centrali tra il ’49 e il ’72. Con il 1645, infatti, si aprì quello che nella storia della meteorologia è conosciuto con il nome di “Minimo di Maunder”, ossia il periodo che fino al 1715 racchiude gli inverni più rigidi degli ultimi mille anni, il cui apice è rappresentato senza ombra di dubbio dall’inverno 1708-09. Il più freddo che la storia documenti. Un dipinto oggi conservato nel corridoio della pinacoteca della Fondazione Querini Stampalia, spesso erroneamente attribuito alla mano di Gabriele Bella, mostra la laguna di Venezia completamente ghiacciata, un fenomeno, come abbiamo detto non raro, ma la stessa sorte toccò un po’ a tutti i grandi fiumi d’Europa e, caso unico, gelò completamente anche il lago di Garda. Bastarono poche ore ad un vento polare che iniziò a spirare la notte dell’Epifania, per congelare in poche ore tutti i corsi d’acqua anche della nostra Regione, a cominciare dal Po la cui crosta di ghiaccio raggiunse i 70 centimetri. La neve raggiunse lo stesso spessore a Rovigo, mentre nel capoluogo veneto la colonnina di mercurio, anzi è meglio di dire di “spirito” visto che proprio in quell’anno Daniel Gabriel Fahrenheit mise a punto il suo termometro che funzionava ad alcol, scese di 17,5° C oltre lo zero termico, un fatto rimasto eccezionale se si pensa che la temperatura più bassa dopo tale data fu – 13,6° C, registrata nell’inverno 1963. Si trattò comunque di una temperatura mite rispetto al resto del Veneto e d’Italia, dove il rigore raggiunse cifre doppie. Si spiegherebbe così l’eccezionale moria di alberi di mele, susine noci e ciliegie che solitamente possono resistere fino a temperature sotto i 40° C, inoltre la laguna si liberò dai ghiacci il 29 gennaio mentre nella pianura la gran quantità di neve e di ghiaccio permise la permanenza del gelo fino a marzo. Al freddo si unì la mancanza di risorse, già a febbraio le disponibilità alimentari iniziarono a scarseggiare, i raccolti dell’estate precedente erano risultati scarsi ovunque e il permanere del gelo aveva paralizzato anche i trasporti. I prezzi dei generi di prima necessità schizzarono alle stelle. Ai morti di freddo e per malattie bronco-polmonari, iniziarono ad aggiungersi quelli per fame. Fu certo di oltre un milione di decessi il pedaggio che dovette pagare l’Europa ai rigori di quell’inverno che per fortuna non ebbe più a ripetersi nei secoli successivi. Per tutto l’Ottocento infatti, malgrado gli inverni rigidi non siano mancati soprattutto nei decenni centrali del secolo, simili situazioni non si verificarono e non si verificarono nemmeno nel corso di quei tre inverni che nella storia del Novecento vennero ricordati come anni “del freddo”.
Nel 1929 la temperatura minima toccata a Padova fu di -15,6° C, di -16,3 C a Vicenza e -20° C a Rovigo. Un freddo tuttavia che per il suo prolungato assedio fu sufficiente per lasciare l’ultima testimonianza di fiumi completamente ghiacciati. Nel 1956, infatti, il Po ghiacciò in alcuni tratti e anche il corso dell’Adige si fermò solo verso la foce. L’ultima vera ondata di gelo polare risale esattamente a trent’anni fa, quando correnti di aria fredda provenienti dal Nord Europa investirono la nostra pianura dal 5 al 16 gennaio, lasciando a terra 30 centimetri di neve a Verona e Venezia, 40 a Padova e 55 a Vicenza. Anche il gelo fu pungente, nel Veneto vennero registrate temperature minime prossime ai – 20° C che eguagliarono i rigori raggiunti il 15 febbraio 1956. Quella fu l’ultima occasione per veder passare nel letto dell’Adige le “beazze” , le grandi lastre di ghiaccio in formazione trasportate dalla corrente. Da allora niente più ghiaccio sotto i ponti dei fiumi, ma neanche sotto quelli dei fossi.