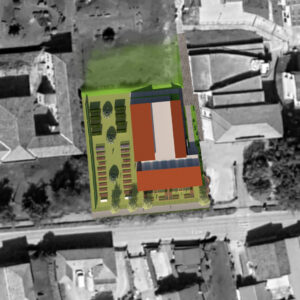La pasta è una lingua italiana

Dentro alla parola ci sono mille connotazioni che vanno oltre il semplice impasto di acqua e farina
Una delle immagini più classiche della tavola tricolore è un bel piatto fumante di lasagne. Ovviamente mi riferisco al “pasticcio” e la precisazione è d’obbligo, in quanto alle nostre latitudini il significato della parola trasla: le lasagne per noi sono quelle che gli altri chiamano tagliatelle e le nostre tagliatelle sono quelle striscioline sottili-sottili che vanno cotte in brodo. In ogni caso stiamo parlando di quella specialissima produzione che un tempo usciva in traslucide sfoglie dal mattarello della nonna per le feste comandate. Oggi con “a mano” si indicano anche quelle strisce tirate con la macchinetta a manovella, ma come archetipo è meglio usare l’immagine della sfoglia avvolta sul liscio legno e pazientemente tirata a mano, rigirata da un verso e dall’altro, e infine spianata con la complicità di qualche tattica spolverata di farina.
Già 400 anni prima di Cristo, Aristofane indicava con la parola “laganon” una piatta sfoglia il cui ingrediente principale era la farina
La pasta all’uovo è l’immagine che ci avvicina di più alle origini, a quelle dei nostri ricordi ma forse non agli albori della nascita della pasta. L’elemento principale, infatti, non sono le uova, che con una certa facilità potevano essere trovate in ogni casa contadina, ma la farina. Già 400 anni prima di Cristo, Aristofane indicava con la parola “laganon” una piatta sfoglia il cui ingrediente principale era proprio il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento. Termine che è passato poi quasi uguale alla civiltà latina “laganum” che Orazio, in epoca augustea, ci informa veniva tagliato a strisce. Sarebbe stato bello ci avesse detto anche come venivano cotte, ma è da escludere venissero prima bollite in acqua come accade adesso.
Nel 1154 il geografo arabo Al Idrin parla di un “cibo di farina in forma di fili” che veniva prodotto a Palermo, confezionato in botti e spedito in tutta Italia
Poi le pasta riemerge dalle coltri del tempo mille anni più tardi e ovviamente per mano di quegli arabi siciliani che ci riconsegnarono le nostre origini classiche, dopo dieci secoli di scorrerie barbare. Nel 1154, infatti, un geografo arabo, Al Idrin, parla di un “cibo di farina in forma di fili” che veniva prodotto a Palermo, confezionato in botti e spedito in tutta Italia. Forse erano gli spaghetti e quindi è da escludere che questi siano stati portati in Italia da Marco Polo dalla Cina, anche perché il frumento nel Celeste Impero era piuttosto raro. Insomma, come sempre, è difficile tornare così indietro nel tempo e trovare le origini di un prodotto che più probabilmente è nato più volte e in diversi posti tra il Medio Oriente e il Mediterraneo classico come evoluzione del grano. Tuttavia è difficile pensare che esista un prodotto più italiano della pasta. Perché è comunque qui che ha trovato la migliore interpretazione, tanto da diventare una sorta di immagine riconosciuta nel mondo, anche se non del tutto positiva, bisogna dire. “Maccaroni”, “mangiaspaghetti” venivano definiti i nostri migranti, oppure “spaghetti&mandolino” è uno dei binomi sbeffeggianti il Bel Paese se volessimo tralasciare il piatto di spaghetti con la pistola che nel 1977 divenne la copertina della rivista tedesca “Der Spiegel”.

Il piatto di spaghetti è l’immagine internazionale che rappresenta l’Italia
Tuttavia non sono stati solo “gli altri” ad associare alla pasta il carattere degli italiani, qualche esempio lo troviamo anche nella poesia nazionale, anzi proprio quella di un padre della letteratura di casa nostra: Giovanni Boccaccio, che nella III novella dell’VIII giornata del Decamerone racconta la vita di ciò che accade nel Paese del Bengodi. “In mezzo alla campagna, a guisa di pentolone, s’erge un basso colle; ricco d’acqua bollente, dove sovra stan genti, che niuna cosa fan che far bìgoli, cuocergli in tal acqua, condirli con liquor d’ulivi, e chi più piglia più se n’ha”. A parte una certa “oziosità” che è rimasta attaccata con l’amido della pasta alla pelle degli italiani, quella descritta dal sommo poeta è forse la prima narrazione della “pasta in bianco”, anche se qualcuno potrebbe obbiettare che “quella vera” ha il burro.
Questione di latitudini, anzi di dislivello: alla quota dove vivono gli olivi la pasta ha l’olio, a quote più elevate è stato il burro ad avere il sopravvento. Tuttavia stiamo parlando di un piatto che nel Medioevo godeva di grande considerazione e che solo recentemente è stato considerato una portata per diete o per ammalati, salvo tornare in auge negli ultimi anni con il riaffermarsi della dieta mediterranea. Infatti, in questo stare “leggeri” e non punirsi nei sapori e nei profumi, i “Bìgoli co òjo” sono fra i migliori esempi di preparazione poco elaborata. Per questo in tante case del Veneto, meno di qualche decennio fa, era ancora presente e funzionante il “tòrcio bigolaro”. Un piccolo torchio da cucina, dove l’impasto di farina bianca e uova era posto nella camera di compressione, si girava la vite in metallo, questa spingeva la pasta verso il basso che usciva dai fori di una piastra in forma di “bìgoli“. Spolverati di farina gialla perché non si attaccassero, i bìgoli erano tagliati a circa venti centimetri. Se si usava la farina di grano saraceno, invece, si ottenevano i “bìgoi mori”. Erano sicuramente, insieme alle lasagne richiamate all’inizio di questo articolo, i “piatti della festa”, preparazioni elette per sottolineare i momenti importanti del calendario rurale.