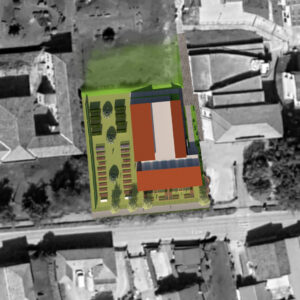Pesci d’acqua dolce, una leccornia data in pasto all’inquinamento

Per secoli la fauna ittica dei nostri corsi d’acqua ha sfamato la popolazione: tinche, carpe, lucci sono sempre stati considerati prede ambite dai pescatori e dai cuochi. Oggi questa ricchezza è andata perduta a causa dello stato dei nostri fiumi
È di questi giorni la notizia che nell’anno in cui Mantova, insieme a Bergamo, Brescia e Cremona, è Capitale Europea dell’Enogastronomia 2017, la città dei Gonzaga ospiterà fino a ottobre anche una rassegna, organizzata da Slow Food che cade a fagiolo anche come tema per le righe che avevamo pensato di farvi leggere: il pesce d’acqua dolce. Una risorsa delle zone rurali ormai dimenticata che un tempo invece costituiva uno degli elementi più a buon mercato che il territorio e i suoi corsi d’acqua metteva a disposizione per integrare la non sempre munifica dieta delle genti contadine e di quella parte di popolazione che non apparteneva alle caste dei ricchi notabili, dei grandi proprietari terrieri o di nobili blasonati. Al tempo andava così! Perché allora non avevano ancora scoperto la facile speculazione proposta da quel modello di sviluppo, ancora attuale, che ha preferito usare le acque interne per scopi che hanno provocato più di un tipo di inquinamento: industriale, con sversamento nei umi di metalli pesanti e idrocarburi quali scarti delle diverse lavorazioni manifatturiere; civile, con depuratori che spesso non ci sono o se ci sono funzionano a scartamento ridotto; agricolo, con relativa contaminazione delle acque dovuta all’eccesso di concimi, pesticidi, o rifiuti di allevamenti di bestiame. Senza poi metter in conto lo spreco dell’acqua che, come dicono in casa Slow Food, crea un vero e proprio “buco nell’acqua” e dove c’è poca acqua…ci sono pochi pesci. Al tempo, dicevamo, invece i pesci venivano pescati, per essere cucinati, proprio in quei corsi d’acqua che ormai sono talmente poco salubri e sicuri che per i pesci di mare, è stato n troppo facile vincere la battaglia contro i loro dolci cugini. Lucci, carpe, tinche, cavedani, barbi, pesce gatto, alborelle, scardole, persico, persico sole, persico reale, storione, vairone, foraguade, saltarelli, anguille e, non ultime, le rane. Che proprio pesci non sono ma erano sempre pronte sul fosso fuori casa per diventare, in stagione, la base per un succulento risotto o una frittura dell’ultimo momento per ospiti arrivati all’improvviso. Insomma una grande disponibilità da quelle acque di pianura che scendendo limpide dalle montagne si dividevano con abbondanza in mille corsi creando un reticolo di canali e fossi che hanno assicurato oltre che l’irrigazione dei campi anche cibo davvero prezioso e buono. Tanto che furono più di una le ricette “inventate” dalle casalinghe e dai maestri di cucina come lo fu il Bartolomeo Scappi, cuoco segreto di Papa Pio V, che nel suo libro terzo, suggeriva l’uso in cucina del pesce d’acqua dolce anche per ribadirne il valore come simbolo di ottimo cibo anche per i periodi quaresimali e quindi non grasso ma comunque capace di soddisfare palato e appetito. Oggi troppo spesso distratti dai gusti del pesce di mare che in realtà, per colpa degli allevamenti intensivi cui è sottoposto questo tipo di alimento, di sapore sapido del mare ha conservato ben poco, soprattutto se messo a confronto con i cosiddetti “pesci di cattura”, sempre meno numerosi per il grigio impoverimento che, oltre a umi e corsi d’acqua di terra, ha coinvolto anche i nostri mari arrivando finanche agli oceani. Sottoposti, anch’essi, a uno stressante sfruttamento dovuto alla frenetica voracità del mondo moderno che cozza, di contro con quelle sacche di mondo povero dove invece il pesce d’acqua dolce è ancora cibo. Buono e che potrebbe tornare a essere protagonista solo se si riflettesse sulla sua grande importanza rispetto al ricorso spropositato verso il pesce di mare, sempre meno pescato e sempre più allevato. Basterebbe infatti riflettere sul fatto che per ottenere un’orata del peso di un chilogrammo bisogna nutrirla con almeno 5 Kg di piccoli pesci o, rinunciando drasticamente alla qualità organolettica, alimentandola con mangimi e integratori la cui origine non è sempre così trasparente o tracciata come quella ben nota a chi un tempo andava a pescare in riva a corsi d’acqua dolce, magari a qualche passo da casa o poco più distante se si doveva raggiunger un qualche fiume. Ritenuto dai pescatori d’acqua dolce come una sorta di oceano, ricco di varietà e specie, dove stagione dopo stagione si alternavano per essere catturati i pesci attraverso le più tecniche più varie, curiose e molto spesso glie di quell’ingegno contadino che ha saputo disegnare per lunghi secoli anche il nostro habitat rurale e i nostri paesaggi no alle pendici dei monti. Dove, nei freddi torrenti, si pescava la trota e la trota salmonata, vera leccornia ancora ben presente sulle tavole dei molti ristoranti e recentemente riproposta da locali stellati che, alla moda di Bartolomeo Scappi, la ripropongono pure in carpione. Metodo ormai ancestrale per gustare e soprattutto conservare quel pesce d’acqua dolce che spesso veniva pescato pure in quantità definite miracolose da limpidi corsi d’acqua che sapevano essere davvero generosi con chi sapeva rispettarli. O rendo un pesce buonissimo, a chilometro zero e a costo bassissimo.
La ricetta: Pesci gatto in umido
Ingredienti
- 8 pesci gatto grandi;
- olio extra vergine d’oliva;
- 4 spicchi d’aglio;
- 1 mazzetto di prezzemolo;
- 3 limoni;
- vino Colli Euganei D.O.C. Merlot;
- 4 foglie d’alloro;
- farina;
- sale.
Procedimento
Tritare l’aglio ed il prezzemolo e soffriggere in olio fino alla doratura dell’aglio.Aggiungere i pesci gatto e l’alloro e coprire con il vino. Far bollire per circa cinque minuti, aggiungere il succo di tre limoni. Lasciare raffreddare e consumare il giorno dopo.