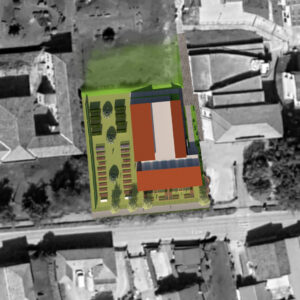Il “pane quotidiano”

Il pane è sempre stato il re della tavola, ma come è stata la sua evoluzione nei secoli? Com’era il pane contadino delle contrade di ieri? E quanta nostalgia per la “ciòpa de pan con la ùa”, merenda divorata durante la ricreazione da noi “antichi” studenti!
“Il 29 giugno, quando matura il grano…..”, cantavano alpini e contadini lombardi e veneti negli anni ’30, felici per il primo vero raccolto annuale che riempiva granai e pance; pance stanche di accogliere la misera polenta intinta nell’olio del “sardelòn”, asciugato dai ripetuti assalti dei numerosi abitanti di ogni famiglia patriarcale! Il frumento arrivava a proposito per riprendere un’alimentazione più equilibrata, dopo un inverno e una primavera passate a “polenta e pòcio”, “polenta e sardelòn”, “polenta infasolà”, “polenta e baccalà”, “polenta e grassiòle”, infine polenta calda e zucchero per noi bambini come dessert! La storia dice che il pane di frumento (esiste anche il pane di Sorgo, di Segale etc..) è il più diffuso nell’area temperata e che la sua origine avvenne tra il Paleolitico e il Neolitico (tra il 10.000 e l’8.000 a.C.), al termine dell’ultima Grande Glaciazione quando la temperatura si innalzò e l’uomo incominciò a coltivare i cereali. Era un impasto di chicchi schiacciati con pietre e uniti all’acqua. Per caso questo impasto di cui si cibavano gli antichi finì vicino al fuoco, così si formò la prima focaccia ancora non lievitata (azzima). Gli archeologi sono concordi nel dire che furono gli Egizi a ottenere la prima lievitazione del pane, popolo che, secondo Erodoto: ”…fece ogni cosa in modo diverso dai comuni mortali”. Inventarono la lievitazione naturale, intorno al 3.500 a.C., conservando una parte dell’impasto per il pane, da unire all’impasto successivo dopo che l’aria e l’umidità lo avevano leggermente acidificato. Ripetendo il procedimento, ritenuto soprannaturale e mantenuto segreto, ottenevano pagnotte gonfie e appetitose, inventando il “Lievito Madre”. Gli Egizi divennero così maestri indiscussi nella panificazione e, nell’oltretomba, si portavano come vivande almeno 15 tipi di pane. Quest’arte passò anche agli Ebrei che mangiavano pane azzimo in occasione della commemorazione dell’esodo dall’Egitto, il pane non lievitato è simbolo dell’accingersi a intraprendere un viaggio, data la rapidità di preparazione e la lunga conservazione. Nell’Ultima Cena, Gesù Cristo spezzò l’Ostia di pane azzimo. Dall’Egitto l’arte della panificazione passò anche in Grecia. I greci divennero ottimi panificatori, aggiungendo alla ricetta base ingredienti come latte, olio, formaggio, erbe aromatiche e miele. Anche a Roma l’arte della panificazione arrivò, però il pane entrò nell’uso quotidiano, secondo Plinio, nel 168 a.C., ad opera di alcuni schiavi catturati in Macedonia. All’epoca dell’Impero Romano il pane era l’alimento base per gran parte della popolazione e bisognava assicurarlo a tutti. Per questo vigeva una specifica legislazione ed era consentito acquistare frumento in pubblici granai ad un prezzo inferiore a quello di mercato. È giusto ricordare che in omaggio alla demagogica promessa di dargli “Panem et Circenses”, veniva distribuito al popolo il pane gradilis (sui gradini), durante i giochi negli anfiteatri.
Durante il Medioevo, l’abilità dei fornai romani si perse con le invasioni barbariche, e solo i monaci mantennero forni per il pane
 Con le signorie il pane fu sottoposto a diversi balzelli per la produzione. Dante, ospite alla Corte Scaligera scrive nel canto XVII del Paradiso: “Tu proverai si come sa di sale lo pane altrui, …” intendendo la difficoltà di mettersi a servizio dei potenti. Il pane quindi come “status”, un paragone sociale, ma anche un bene da gestire e da far pesare come quando il Signore caccia Adamo dall’Eden dicendoli: “Ti guadagnerai il pane col sudore della fronte!”. Nel Rinascimento ogni categoria sociale aveva il “suo” pane, come pure esisteva il pane del boia che veniva accantonato dai fornai rovesciato, in segno di disprezzo. Ancor oggi mettere in tavola il pane capovolto è segno di disprezzo e foriero di sfortune! Nell’Italia del ‘600 la miseria dilagava, assieme alle pestilenze di manzoniana memoria, così i monaci costruirono le “Graniche” o “Grance”, da cui il vulgo Granze, toponimo presente in ogni nostro paese, luoghi per immagazzinare il grano prodotto nelle loro vaste proprietà per poi rivenderlo al popolino affamato, in cambio di lavoro o altre prestazioni d’opera, mentre per la macina del grano si posizionarono mulini ad acqua nei fiumi più importanti del territorio, come l’Adige e il Fratta-Gorzone, mulini che resistettero fino all’arrivo della corrente elettrica della prima metà del ‘900, quando in ogni paese e frazione se ne costruirono di moderni dove ognuno macinava il proprio grano o frumentone.
Con le signorie il pane fu sottoposto a diversi balzelli per la produzione. Dante, ospite alla Corte Scaligera scrive nel canto XVII del Paradiso: “Tu proverai si come sa di sale lo pane altrui, …” intendendo la difficoltà di mettersi a servizio dei potenti. Il pane quindi come “status”, un paragone sociale, ma anche un bene da gestire e da far pesare come quando il Signore caccia Adamo dall’Eden dicendoli: “Ti guadagnerai il pane col sudore della fronte!”. Nel Rinascimento ogni categoria sociale aveva il “suo” pane, come pure esisteva il pane del boia che veniva accantonato dai fornai rovesciato, in segno di disprezzo. Ancor oggi mettere in tavola il pane capovolto è segno di disprezzo e foriero di sfortune! Nell’Italia del ‘600 la miseria dilagava, assieme alle pestilenze di manzoniana memoria, così i monaci costruirono le “Graniche” o “Grance”, da cui il vulgo Granze, toponimo presente in ogni nostro paese, luoghi per immagazzinare il grano prodotto nelle loro vaste proprietà per poi rivenderlo al popolino affamato, in cambio di lavoro o altre prestazioni d’opera, mentre per la macina del grano si posizionarono mulini ad acqua nei fiumi più importanti del territorio, come l’Adige e il Fratta-Gorzone, mulini che resistettero fino all’arrivo della corrente elettrica della prima metà del ‘900, quando in ogni paese e frazione se ne costruirono di moderni dove ognuno macinava il proprio grano o frumentone.
Un’importante rivoluzione nel campo della panificazione fu l’introduzione (secoli fa) del lievito di birra al posto della lievitazione naturale, così nel settecento i fornai riscoprirono i vari tipi di pane ideati dai greci, per accontentare i gusti raffinati delle classi più agiate, mentre il popolino doveva accontentarsi di avere il pane in tavola saltuariamente, cuocendolo nei loro casoni di canne, paglia e fango, tra il fumo del camino posizionato al centro del casone. Lo stesso Doge Andrea Vendramin, nel 1477 scriveva: “…gran parte d’omeni del terren padoan dorme suso la paglia, gran parte vive de herbe senza pan e quelli che stan meglio vive de pan de sorgo et de semoloti…”. Per arrivare al buon pane fatto in casa, tradizione durata fino alle soglie della Seconda guerra mondiale nelle case contadine, bisogna attendere ancora fino al ’800, quando si costruiscono grandi corti con forno per il pane  che serviva per tutta la contrada. La sera la massaia preparava nella mèsa (contenitore in legno a sezione di trapezio rovescio) l’impasto di farina bianca, sale, acqua e lievito madre. Lo amalgamava con la gramòla azionato da due robusti ragazzotti della famiglia, per riporlo, coperto da un panno, nella mèsa e portato a lievitare nella camera della sposa, simbolo di fertilità. Di buon’ora, il mattino dopo, si riprendeva l’impasto lievitato, lo si amalgamava nuovamente nella gramòla, lo si divideva in piccole dosi per formare le pagnotte, si incideva un segno di croce in ognuna e infarinandole le si riponeva nella mèsa per portarle a cuocere nel forno a legna già acceso da ore. Una volta cotte le si spolverava dalla cenere e rimettendole nella mèsa le si portava a casa, riponendole in ceste che venivano attaccate alle travi della cucina. Non si mangiava fuori dall’orario prestabilito per tutta la famiglia! Il pane prodotto con le farine di un tempo era più consistente di quello odierno, di una fragranza dimenticata e poteva conservarsi per più giorni senza indurire troppo, così il pane in casa lo si faceva di regola ogni settimana. Poi i fornai si sono attrezzati con impastatrici meccaniche, spezzatrici, formatrici e con forni moderni, le farine sempre più raffinate e bianche, anonime. I garzoni dei fornai, nel secondo dopoguerra, incominciarono a portare il pane nelle famiglie, anche di campagna, con enormi ceste montate sulle biciclette, e il pane fatto in casa è scomparso, ed è un vero peccato, soprattutto per la poesia del mistero che accompagnava la formazione del Lievito Madre. Sembra che fosse indispensabile unire alla farina, all’olio e al miele la rugiada raccolta sfiorando con un piatto l’erba alta e il trifoglio, formata nella magica notte di San Giovanni (23 giugno, solstizio d’estate), rugiada che la leggenda vuole fossero le lacrime di Erodiade, pentita per aver comandato la morte di San Giovanni Battista. È anche un peccato non avere il pane fatto con la propria farina, del proprio grano, prodotto seminando il grano dell’anno prima, quasi un’eredità famigliare. Ora è tutto anonimo e impersonale, salvo i nomi di fantasia che spiccano nelle colorate confezioni di ogni prodotto alimentare industriale.
che serviva per tutta la contrada. La sera la massaia preparava nella mèsa (contenitore in legno a sezione di trapezio rovescio) l’impasto di farina bianca, sale, acqua e lievito madre. Lo amalgamava con la gramòla azionato da due robusti ragazzotti della famiglia, per riporlo, coperto da un panno, nella mèsa e portato a lievitare nella camera della sposa, simbolo di fertilità. Di buon’ora, il mattino dopo, si riprendeva l’impasto lievitato, lo si amalgamava nuovamente nella gramòla, lo si divideva in piccole dosi per formare le pagnotte, si incideva un segno di croce in ognuna e infarinandole le si riponeva nella mèsa per portarle a cuocere nel forno a legna già acceso da ore. Una volta cotte le si spolverava dalla cenere e rimettendole nella mèsa le si portava a casa, riponendole in ceste che venivano attaccate alle travi della cucina. Non si mangiava fuori dall’orario prestabilito per tutta la famiglia! Il pane prodotto con le farine di un tempo era più consistente di quello odierno, di una fragranza dimenticata e poteva conservarsi per più giorni senza indurire troppo, così il pane in casa lo si faceva di regola ogni settimana. Poi i fornai si sono attrezzati con impastatrici meccaniche, spezzatrici, formatrici e con forni moderni, le farine sempre più raffinate e bianche, anonime. I garzoni dei fornai, nel secondo dopoguerra, incominciarono a portare il pane nelle famiglie, anche di campagna, con enormi ceste montate sulle biciclette, e il pane fatto in casa è scomparso, ed è un vero peccato, soprattutto per la poesia del mistero che accompagnava la formazione del Lievito Madre. Sembra che fosse indispensabile unire alla farina, all’olio e al miele la rugiada raccolta sfiorando con un piatto l’erba alta e il trifoglio, formata nella magica notte di San Giovanni (23 giugno, solstizio d’estate), rugiada che la leggenda vuole fossero le lacrime di Erodiade, pentita per aver comandato la morte di San Giovanni Battista. È anche un peccato non avere il pane fatto con la propria farina, del proprio grano, prodotto seminando il grano dell’anno prima, quasi un’eredità famigliare. Ora è tutto anonimo e impersonale, salvo i nomi di fantasia che spiccano nelle colorate confezioni di ogni prodotto alimentare industriale.
Con nostalgia penso al pane comune, non proprio bianco, che mi ha fatto crescere, al pane con l’olio della festa, al pane biscotto inzuppato nel brodo di cappone e cannella, dei giorni della trebbiatura, ma in particolare al pane con l’uvetta che comperavo al forno da “Arturo”, prima di andare a scuola, con le 15 Lire della mancia di mia nonna. Al momento della ricreazione liberavo dalla carta da pane la “ciopa”, confrontandola con quella dei miei compagni per vedere quale era più grande e quale avesse più chicchi di uva passa! Ma il confronto durava poco, il tempo di pochi morsi e poi via nel cortile con nuova energia a rincorrere qualche stupita lucertola o a giocare a “saltamussa” o a nascondino con gli amici, interrotti poi dal richiamo della maestra per riprendere i nostri sudati apprendimenti!