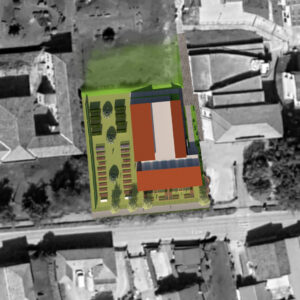Il caso Polesine: terra troppo fertile per produrre vino

Nei secoli passati la grande abbondanza di acqua ha reso redditizie altre coltivazioni rispetto alla vite, così progressivamente oltre alla sua coltura è andata perdendosi anche la cultura legata alla vinificazione
Vien da chiedersi come mai certe terre abbiano una vocazione vitivinicola e certe altre no. Certo a volte sono le condizioni pedoclimatiche a determinare la qualità e dunque il successo di un vino, ma non sempre è così. Del resto su terre impervie si arroccano gli antichi vigneti del monte Calvario, mentre quelli del Bosco Eliceo vivono su suoli sabbiosi. E che dire di quelli a strapiombo sul mare della Costa d’Amalfi? O dei “vigneti di mare” dell’Isola d’Ischia? E ancora quelli delle pendici del Monte Etna? O di Salina e Pantelleria? No la terra a volte centra poco, centrano di più le ragioni culturali ed è proprio in questo modo che ci si può spiegare come il Polesine non sia una terra di vini. Poi, che non lo sia non è neanche vero fino in fondo, in quanto c’è stato un tempo in cui il vino Polesano era tenuto in gran considerazione. Secondo lo storico inglese Hugh Johnson, autore di una sistematica “Storia del vino”, nel passare in rassegna i “Grands Crus” della Roma antica, colloca ai primi posti il “vinum Hadrianum”, la cui produzione si situava nei pressi di Adria. Un primato vitivinicolo che probabilmente è rimasto invalso anche durante l’Alto Medioevo, tanto che al tempo la vite risultava una coltura specializzata, presente in un appezzamento a sé stante circondato da fossati e siepi, clausure. I vigneti erano sostenuti dal “palo secco”, e quindi è da immaginare che la di fusione della coltura promiscua, con alberi da frutto o con alberi ombreggianti vivi, si sia diffusa più tardi, evolvendo poi verso il sistema della “piantata” padana che diventerà caratteristico fino al tempo recente. Ma la coltura della vite aveva anche un secondo scopo, come risulta dagli atti dei Certosini di Corcrevà, risalente al 1489, essa infatti radicava il colono alla terra. Non c’è da stupirsene, siamo negli anni delle prime boni che: grandi distese di terra venivano liberate dall’acqua e questa dovevano essere lavorate. Pertanto i grandi proprietari, laici o ecclesiastici, obbligavano, alla coltivazione della vite e a mantenerne intatto il numero fornendo essi stessi le piante.
Le cose dunque in Polesine, per quanto riguarda la vite, devono essere mutate in seguito all’inserimento di nuove colture come ad esempio il mais, la cui diffusione nel resto d’Italia inizia proprio da qui nel 1554. La grande presenza di acqua, infatti, deve aver stimolato nei tempi in cui le produzioni non erano più strettamente legate alla sussistenza, speculazioni verso quei prodotti che sfruttavano in modo più profondo le caratteristiche geomorfologiche del territorio. Il riso e la canapa, per esempio, venivano imposte dalla Repubblica di Venezia: il primo come coltura di bonifica nelle terre appena prosciugate e la seconda come pregiata materia prima per l’indotto dell’Arsenale. Fatto sta che alla fine del XIX secolo le cronache restituiscono un Polesine totalmente incapace di produrre vino di qualità. Il primo materiale utile per un’indagine sulle tecniche dei vignaioli del tempo, è una monografia redatta dal fattore dei Papadopoli Giacomo Bisinotto al tempo dell’Inchiesta Agraria nel 1882, dalla quale emerge un quadro piuttosto desolante per la coltivazione della vite. “La vite – scriveva – la si tiene appaiata agli alberi lungo i lari delle sistemate campagne; solo alcuni fra i più solerti agricoltori da qualche anno impresero a coltivarla a vigneto. I vitigni che prevalgono si nominano: marzemino, friularo, corbino, corbinello, uva d’oro, pateresco, basegano, padovano, ecc”. Tuttavia non esistevano uve per un vino “distinto”, riconoscibile e connotabile, ma molti tipi coesistevano senza alcuna omogeneità. La ragione risiedeva nella necessità di premunirsi contro l’aleatorietà del tempo e il pericolo che le gelate potessero pregiudicare irrimediabilmente la raccolta se tutte le viti fiorivano nel medesimo periodo. Inoltre, essendo inveterato l’uso di vendemmiare contemporaneamente senza distinguere il momento ideale di maturazione delle singole uve, facendo una sola vendemmia, l’uva più matura avrebbe fornito lo zucchero, e quella meno matura l’acidità. Il compromesso era più che ragionevole seppur a scapito della qualità.  Insomma al tempo certo si guardava più, alla quantità che alla “bontà” e del resto i vigneti non dovevano produrre solo vini. “Il metodo prevalente di tenere i vigneti – scriveva Giacomo Agostinetti sul finire del ‘600 in un volume destinato a fattori e castaldi – è quello di maritare le viti agli alberi lungo le stréne, a pioppi, olmi, oppi o salici che siano, a motivo del guadagno di pertiche e fascine, della foglia per alimentare il bestiame e per- ché la chioma degli alberi protegge i grappoli dalla grandine”. Dalla potatura dipende, si sa, la raccolta ed in Polesine a quel tempo vigeva un modo redditizio di bruscare, articolato in tre anni successivi: “Il primo anno che li salgari hanno le pertiche longhe di tre anni, li troncano e tirano li capi delle vide che sono lunghi da un arbore all’altro; il secondo anno lasciano le tirelle vecchie e gettano sopra li capi giovani; il terzo anno tagliano tutto il vecchio dell’uno e dell’altro anno et il quarto anno tornano a ripigliar l’istesso ballo, chiamando questo loro bruscar l’uno di pertica, l’altro di spiron, et l’altro anguanino; e perciò costumano far la possession in tre parti per haver ogn’anno d’ogni sorte di cose, cioè legne, vin buono, mezano et inferiore”. Ma se la situazione nelle campagne non è tra le più incoraggianti, in cantina – dalla relazione di Bisinotto – emerge una situazione anche più desolante.
Insomma al tempo certo si guardava più, alla quantità che alla “bontà” e del resto i vigneti non dovevano produrre solo vini. “Il metodo prevalente di tenere i vigneti – scriveva Giacomo Agostinetti sul finire del ‘600 in un volume destinato a fattori e castaldi – è quello di maritare le viti agli alberi lungo le stréne, a pioppi, olmi, oppi o salici che siano, a motivo del guadagno di pertiche e fascine, della foglia per alimentare il bestiame e per- ché la chioma degli alberi protegge i grappoli dalla grandine”. Dalla potatura dipende, si sa, la raccolta ed in Polesine a quel tempo vigeva un modo redditizio di bruscare, articolato in tre anni successivi: “Il primo anno che li salgari hanno le pertiche longhe di tre anni, li troncano e tirano li capi delle vide che sono lunghi da un arbore all’altro; il secondo anno lasciano le tirelle vecchie e gettano sopra li capi giovani; il terzo anno tagliano tutto il vecchio dell’uno e dell’altro anno et il quarto anno tornano a ripigliar l’istesso ballo, chiamando questo loro bruscar l’uno di pertica, l’altro di spiron, et l’altro anguanino; e perciò costumano far la possession in tre parti per haver ogn’anno d’ogni sorte di cose, cioè legne, vin buono, mezano et inferiore”. Ma se la situazione nelle campagne non è tra le più incoraggianti, in cantina – dalla relazione di Bisinotto – emerge una situazione anche più desolante.
“La fabbricazione del vino vien fatta comunemente dai singoli proprietari: vendesi però una rilevante quantità d’uva pigiata ad osti ed a privati, che finiscono la riduzione del mosto in vino nelle loro cantine. La manifattura del vino, rare eccezioni fatte, è quale la faceva il buon Noè. Nessuna cura della scelta dell’uva, né dell’epoca della vendemmia. La pigiatura si fa all’aperto nei campi, ed il tempo della bollitura giunge per taluno, si può dir, no alla dimenticanza! Da ciò vini non serbevoli e di poco pregio quando con l’osservanza delle più elementari prescrizioni dell’arte enologica, vi sarebbe modo di ottenere discreto vino e conservabile, quale lo si riscontra nelle cantine di qualche intelligente proprietario”. Insomma la terra “da buon vino” c’era come c’era sempre stata, quella che nel tempo venne a mancare fu proprio la cultura nel produrlo. Sempre le righe del Bisinotto restituiscono una varietà di “convinzioni” che animavano i nostri progenitori vignaioli, che oggi paiono commoventi alla luce delle nuove tecniche enologiche. “La svinatura si fa pei vini neri dall’ottavo al quindicesimo giorno dopo la pigiatura; pei bianchi quasi sempre dall’ottavo al decimo, qualche volta dal ventesimo al trentesimo…”. Tale consuetudine era dovuta alla esigenza di dar corpo e colore al vino che diventava tanto più scuro quanto più rimaneva nei tini con l’unico vantaggio di un maggior contenuto di tannino. Al tempo, infatti, le preferenze dei consumatori si accordavano a vini fortemente “colorati”, e chi produceva sapeva tenerne conto. “Si ottiene dovunque un vino ben colorato col ripigiare le vinacce nel tino durante la pigiatura, il che dicesi “follare il cappello”. In qualche luogo e in qualche annata, quasi non bastasse, si rinforza il colore colla “crepata”, ossia col far cuocere dell’uva nel paiolo per poi mescolarla nel tino all’altra che fermenta”. Inoltre, sino a poco tempo fa, vigeva l’uso di porre nei tini durante la fermentazione alcuni oggetti di ferro, come catene, vomeri o catenacci, con l’intento di rendere il vino più resistente. Nella pratica giocava la credenza nelle virtù magiche e terapeutiche del ferro cui si assegnava il potere di prolungare la durata del vino e di evitare che potesse essere influenzato negativamente dai tuoni. Pratiche che potrebbero essere considerate ingenue credulonerie, figlie di un tempo in cui era la scaramanzia ad avere la meglio sulla scienza, tuttavia l’uso di sciogliere sostanze particolari nel vino era di uso sin dall’antichità: i Romani vi immergevano l’ambra, nel Medio Evo veniva scaldato ed infuso l’oro, specchio del sole e del cuore, che avrebbe offerto un efficace cardiotonico, in una stretta relazione tra medicina, alchimia e sica. Certo erano pratiche che non deponevano a favore della qualità del vino, o almeno del vino come lo intendiamo noi adesso. Ma ad incidere su tutto era appunto la mancanza di una cultura dedicata al vino, la necessità di usa di ottenere dal vigneto non solo l’uva e pratiche di cantina dove molto spesso il vino prendeva l’odore dei salami, dei formaggi e degli altri prodotti destinati alla tavola contadina. Valori volatili, per dirla con parole prese in prestito da un qualsiasi sommelier, che probabilmente spaziavano dal rancido alle muffe e a qualsiasi altro miasma emanato da quei luoghi dove al tempo venivano stipate quelle cose che oggi destiniamo al frigorifero. Dalla disamina di Bisinotto emerge anche una certa propensione dei produttori del tempo a puntare esclusivamente all’immediato profitto della vendita dell’uva e, tuttavia, non va trascurato che fino a non molto tempo fa l’uva serviva quasi esclusivamente per produrre vini destinati all’autoconsumo. E quindi la qualità veniva dopo molte altre cose, soprattutto nell’Ottocento quando nelle campagne la povertà era endemica. D’altra parte “i ricchi – per dirla con Goethe – vogliono buon vino, i poveri molto vino”.  In poche parole: il vino polesano era destinato al consumo popolare, chi poteva si rivolgeva al vino d’importazione. Giacomo Bisinotto, così attento e meticoloso, puntuale e preciso nella sua relazione per quanto riguarda le boni che, le arature, le rese di frumento e mais, sul vino pare toccare l’argomento velocemente solo perché il dovere glielo impone. In fin dei conti sa perfettamente che il Veneto, dopo l’Unità, ha perso il fiorente mercato austriaco, che la peronospera infuria nelle zone umide e che ai proprietari convengono mais e foraggio per l’allevamento di vitelli per i quali si “hanno molte pasture”. La perdita della coltura della vite in Polesine, insomma, è figlia di emergenze più gravi, di un tempo di ristrettezze in cui gli sforzi erano appena sufficienti per il necessario e la qualità, nell’economia della sussistenza, era un semplice orpello. Non era la fertilità della terra a mancare, il Polesine del resto – usando termini illustri – “è terra di promissione che frutta al dispetto del mondo che se queste nostre terre di Trevisana fossero trattate come quelle di Polesine, non potessimo vivere a mezza strada”.
In poche parole: il vino polesano era destinato al consumo popolare, chi poteva si rivolgeva al vino d’importazione. Giacomo Bisinotto, così attento e meticoloso, puntuale e preciso nella sua relazione per quanto riguarda le boni che, le arature, le rese di frumento e mais, sul vino pare toccare l’argomento velocemente solo perché il dovere glielo impone. In fin dei conti sa perfettamente che il Veneto, dopo l’Unità, ha perso il fiorente mercato austriaco, che la peronospera infuria nelle zone umide e che ai proprietari convengono mais e foraggio per l’allevamento di vitelli per i quali si “hanno molte pasture”. La perdita della coltura della vite in Polesine, insomma, è figlia di emergenze più gravi, di un tempo di ristrettezze in cui gli sforzi erano appena sufficienti per il necessario e la qualità, nell’economia della sussistenza, era un semplice orpello. Non era la fertilità della terra a mancare, il Polesine del resto – usando termini illustri – “è terra di promissione che frutta al dispetto del mondo che se queste nostre terre di Trevisana fossero trattate come quelle di Polesine, non potessimo vivere a mezza strada”.